Nel nostro ordinamento, il principio della bigenitorialità costituisce un caposaldo della disciplina dell’affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce espressamente che il figlio ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da ciascuno di essi. Tuttavia, questa disposizione non implica che tale rapporto debba essere imposto in modo rigido o insensibile al vissuto soggettivo del minore.
Nel bilanciamento tra il diritto del genitore alla frequentazione e l’interesse del figlio, la legge impone un orientamento centrato sul benessere psicofisico del minore, così come previsto anche dall’art. 337-octies c.c. Di conseguenza, il diritto di visita non si configura come un obbligo assoluto né, tanto meno, coercibile, ma come uno strumento da modulare caso per caso, tenendo conto della capacità di discernimento del minore e della sua volontà, purché questa risulti genuina, stabile e non frutto di condizionamenti esterni.
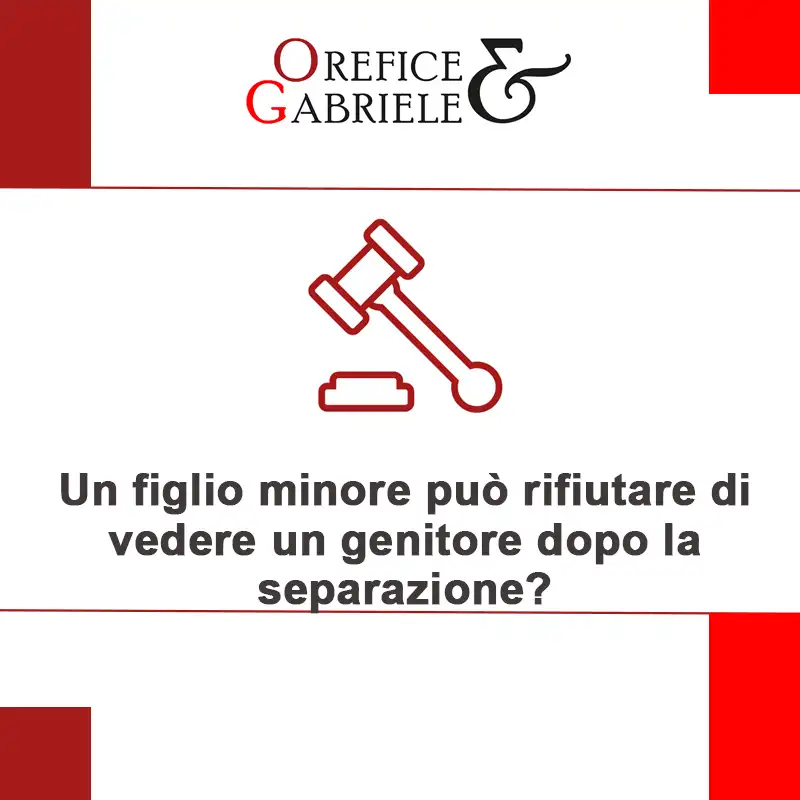
Il ruolo del giudice e l’ascolto del minore
Con la Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), è stato rafforzato l’obbligo per il giudice di procedere all’ascolto del minore, ai sensi dell’art. 473-bis.6 c.p.c., ogniqualvolta debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano direttamente, come quelli sull’affidamento, sul collocamento o sul diritto di visita.
Il legislatore ha elevato l’ascolto a vero e proprio diritto soggettivo del minore, da esercitare preferibilmente in forma diretta, senza mediazioni, ogni qualvolta questi abbia compiuto i 12 anni o anche prima, se capace di discernimento. In tali contesti, il giudice ha l’obbligo di accertare le ragioni del rifiuto eventualmente manifestato verso uno dei due genitori, avvalendosi anche del supporto di consulenti tecnici, psicologi o servizi sociali.
L’ascolto, però, non può essere inteso come un semplice atto formale, ma deve essere inquadrato all’interno di un percorso volto a ricostruire la volontà autentica del minore, distinguendola da eventuali pressioni, manipolazioni o alleanze disfunzionali all’interno del contesto familiare. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21969/2024, ha precisato che un “rifiuto consapevole e motivato del minore costituisce un limite invalicabile al diritto di visita, anche in assenza di condotte pregiudizievoli da parte del genitore escluso”.
Il principio di non coercibilità del legame affettivo
La giurisprudenza ha ormai affermato con chiarezza che i legami affettivi non possono essere imposti per via giudiziaria. La Cassazione ha ribadito, in più pronunce (tra cui la n. 13400/2019 e la già citata n. 21969/2024), che non è possibile costringere un figlio, anche minore, a frequentare un genitore che rifiuta con coerenza, maturità e stabilità emotiva.
L’eventuale imposizione forzata di incontri o il ricorso a meccanismi sanzionatori in assenza di una accertata responsabilità del genitore collocatario, rischierebbe di compromettere ulteriormente l’equilibrio psichico del figlio, aggravando il disagio e vanificando lo stesso principio di bigenitorialità che si vorrebbe difendere.
Tale impostazione giurisprudenziale pone al centro l’interesse superiore del minore, in linea con quanto affermato dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), ratificata dall’Italia con la legge 176/1991.
Alienazione parentale, condizionamento e responsabilità genitoriali
Quando un minore manifesta un rifiuto netto e prolungato nei confronti di un genitore, è doveroso interrogarsi sulle reali cause di tale atteggiamento. La giurisprudenza distingue tra rifiuto spontaneo e rifiuto indotto o manipolato. In quest’ultimo caso si parla – anche se con prudenza – di dinamiche riconducibili all’alienazione parentale.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato, con la sentenza n. 17903/2023, che l’alienazione non può essere desunta automaticamente dal solo rifiuto espresso dal minore, ma deve essere provata con elementi concreti, quali comportamenti ostativi del genitore collocatario, atteggiamenti denigratori sistematici o condizionamenti ripetuti nel tempo.
Se il giudice accerta un condizionamento attivo o passivo da parte del genitore convivente, può adottare provvedimenti correttivi, come il trasferimento del collocamento, la revisione dell’affidamento o l’attivazione di servizi sociali. Ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., è prevista anche la possibilità di sanzioni economiche o la condanna al risarcimento dei danni per lesione della relazione affettiva.
Gli strumenti di intervento e le soluzioni giudiziarie
Quando il rifiuto del minore appare giustificato da un vissuto di disagio profondo o da conflitti irrisolti tra i genitori, il giudice ha il compito di individuare soluzioni personalizzate che non aggravino ulteriormente la sofferenza. Tra le misure frequentemente adottate figurano:
- l’affiancamento di un supporto psicologico al minore;
- l’attivazione di percorsi di mediazione familiare;
- l’organizzazione di incontri protetti in spazi neutri;
- l’intervento di un educatore o tutor familiare;
- nei casi estremi, la sospensione temporanea delle visite, come disposto dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 24651/2022.
Nei casi più delicati, la giurisprudenza riconosce anche la possibilità di prevedere il collocamento temporaneo del minore presso parenti terzi o strutture protette, al fine di ricostruire un contesto neutrale in cui rielaborare il trauma relazionale, come già stabilito dalla Cass. Civ. n. 317/1998
Il limite dell’intervento giudiziario e il ruolo del contesto familiare
Nonostante l’ampiezza degli strumenti a disposizione del giudice, va sottolineato che l’apparato giurisdizionale non sempre è in grado di rispondere con la rapidità e la profondità che la delicatezza di queste situazioni richiede. I tempi della giustizia spesso non sono compatibili con le esigenze evolutive del minore, e talvolta gli interventi arrivano tardi o risultano inefficaci.
Il supporto dei servizi sociali e delle équipe multidisciplinari risulta allora essenziale, così come l’eventuale nomina di un curatore speciale per il minore, figura che può svolgere un ruolo di mediazione e raccordo tra i vari attori del processo, promuovendo il superiore interesse del figlio al di là delle posizioni contrapposte dei genitori